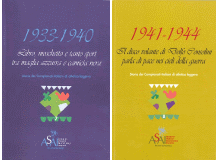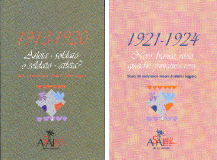Il nostro socio Giorgio Reineri chiude con un commento finale il suo spazio-opinione sul nostro sito in occasione dei Campionati mondiali di atletica a Mosca. Opinione, e, come tale, condivisibile o meno. Prima e durante i mondiali abbiamo provato a lanciare una proposta: la lettera aperta di Luciano Barra al presidente della IAAF, lettera che conteneva molti spunti, e le "opinioni" di Reineri. Nessuno ha niente da dire? aggiungere? criticare? o come sempre la risposta alla discussione è lasciata al mugugno, al brontolio indistinto dove non si riesce mai a capire cosa vogliono coloro che stanno, a qualsiasi titolo, dentro l'atletica? Storia vecchia e risaputa. E non è un caso che siamo finiti dove stiamo: in fondo al gruppo. In silenzio.
Cinque giorni son passati da quando lo stadio Luzhniki di Mosca ha chiuso i battenti, per non riaprirli forse mai più. In nome del calcio-trionfante e della speculazione-rampante, l’antico impianto, costruito a metà degli anni Cinquanta e rimodernato a metà di quelli Novanta, dovrebbe esser abbattuto per lasciar posto ad una mostruosa costruzione da centomila spettatori (contro i cinquantamila di oggi). Così, si dice, pretenderebbe la FIFA, che a Mosca celebrerà i riti pallonari del 2018; e così pare vadano reclamando alcuni furbi costruttori moscoviti, che non vedono l’ora di far la cresta su di un budget che varia tra dai 10 ai 28 miliardi di rubli (230-690 milioni di euro). A rischio sparizione non c’è soltanto un bel po’ di storia sportiva russo-sovietica – in quello stadio si tennero le Universiadi 1973 e i Giochi Olimpici 1980 oltre a concerti e spettacoli: tra gli altri, i Rolling Stones, Madonna e la rock star Viktor Tsoi – ma anche uno dei più bei parchi d’Europa, affacciato sulla Moscova e dominato dalla mole gotico-stalinista dell’Università Lomonosov, prossimo ad essere cementato per uso alberghiero-commerciale.
Così, la nostalgia che abbiamo avvertito al calar del sipario sui XIV campionati del mondo di atletica si è rinnovata nel momento in cui ci lasciavamo alle spalle quell’oasi di verde e maestose architetture. Perchè proprio nell’immensità silenziosa del parco aveva avuto una svolta – or sono giusto quarant’anni – la nostra professione di cronisti: cercare di scrutare, oltre le imposizioni del regime, la realtà del comunismo sovietico.
Ma è davvero cambiata la Russia? Un amico d’anta’n – Igor Ter Ovanesian – ci ha detto categorico: “Un tempo avevamo gli zar, poi abbiamo avuto il segretario del partito comunista e adesso abbiamo Putin. Ma sotto la superficie luccicante di oggi, sotto il rombare delle Rolls Royce, delle Ferrari, delle Porsche e delle Mercedes, tutto è rimasto come prima. Il commercio della anime morte continua, indisturbato ed eterno”.
Igor Ter Ovanesian - il principe Igor degli anni Sessanta, ex primatista del mondo di salto in lungo e per cinque edizioni protagonista olimpico di questa specialità – e’ oggi un artista che ha fatto della pittura rifugio e diletto. Ma è ancora un sommo competente di atletica, con un occhio svelto a leggere il talento e a valutare il valore dei campioni. Ebbene, in chiusura dei campionati proprio Ter Ovanesian ci ha detto d’essersi divertito e di aver apprezzato la manifestazione. Nessun record, ha commentato, ma i salti in lungo di Menkov, il triplo di Tamgho, l’asta di Isinbaeva, l’alto di Bondarenko luccicavano come fossero stati altrettanto primati.
Come contraddire un antico saggio quale è il principe Igor? Sarebbe pura presunzione sostenere una tesi contraria: i giochi mondiali sono stati degni del loro nome, e anche alcune competizioni non sfavillanti in termini cronometrici hanno garantito lo spettacolo. O forse che le volate di Mo Farah non lo furono? E la rivelazione della keniana Sum sugli 800 metri non ha di grazia rappresentato una perfetta sintesi dell’atletica? Eleganza di passo, agilità di movimenti, giudizio tattico e una grazia speciale, che discendeva pure dalla statuaria bellezza della signorina.
I nove giorni di gare hanno, a giudizio di questo ex cronista, offerto spunti di gioiosa ricreazione e di autentico piacere per i millanta gusti dei quasi 400mila spettatori dello stadio. Ma, a sentire commenti, hanno pure appagato il desiderio di spettacolo di chi, lontano, s’era affidato alle immagini televisive. Insomma, anche in un anno post-olimpico, per definizione mai troppo brillante, l’atletica è riuscita a farsi apprezzare.
Il problema, per chi dirige il carrozzone, è di non lasciar svanire quell’apprezzamento ma riuscire a raccogliere qualche nuova adesione, così da rinvigorire questa religione laica dell’uomo.
Ci sono, tuttavia, zone grigie. O zone dove, addirittura, la luce atletica pare essersi spenta. Si prendano gli Stati Uniti: oltre ad esser stati superati, in numero di medaglie d’oro, dalla Russia (6 a 7), per la prima volta i suoi velocisti hanno subito un pesante cappotto, più pesante addirittura di quello di Monaco ’72. Tra gli uomini e tra le donne, una debacle, ove si escluda Justin Gatlin. Mai era successo, difatti, che gli sprinter Usa ottenessero meno medaglie dei mezzofondisti: ottocentisti e millecinquecentisti di entrambi i sessi, difatti, sono stati assai più brillanti dei colleghi centisti e duecentisti. Ma non si creda che questo sia un caso. È, invece, il risultato della sparizione dell’atletica in larghe parti dell’America, e soprattutto della sua sparizione dai mezzi di comunicazione: televisione e stampa scritta. Sui quotidiani Usa si parla di atletica soltanto in due occasioni: per redigere “obituaries”, cioè i necrologi di campioni defunti, o per casi di doping, ultimo quello di Tyson Gay. Tutto ciò - l’atletica considerata attività di sopravvissuti - ha fatto sì che questa disciplina venga sempre più spesso depennata dalle attività sportive dei colleges. Dovendo tagliare i budget, le università hanno tagliato l’atletica, eliminando le borse di studio che un tempo erano riservate a migliaia di giovani corridori, saltatori, lanciatori. E questi, considerati i costi proibitivi della frequenza universitaria, si sono rivolti al football e al basket (e, in minima parte, ora anche al calcio). Si è così andata inaridendo la principale, anzi la unica, fonte di reclutamento negli Stati Uniti: da qui, il dominio giamaicano e la debacle americana.
Somiglia a quella degli Usa, la debacle italiana. Somiglia, ma non è certo la stessa cosa perchè l’America, considerata la ricchezza delle sue etnie, potrà ancora avere sussulti; l’Italia, invece, nessuno.
Da noi, lo sport è moribondo. Tutto lo sport, non soltanto l’atletica o il nuoto. Anche il calcio è in rianimazione, sopravvivendo soltanto grazie all’ossigeno straniero. Ma se il calcio fruisce di una pubblicità a tempo pieno – 24 ore su 24 – l’atletica mette a stento assieme 24 minuti il trimestre. Via dalla tivù, via dai giornali, essa è ormai sconosciuta ai giovani. I quali, già pigri del loro, figurarsi se penseranno mai d’affrontare le fatiche, i sacrifici, le incertezze dell’agonismo professionale.
Non c’è dunque da stupire che l’Italia abbia fatto, a Mosca, la parte dell’intrusa. Assente dalla maggioranza delle gare; e quando presente si era lì soltanto per fare numero, riempiendo le corsie. O, certo, l’Italia non è l’unico paese europeo in agonia: Spagna, Romania, Bulgaria, Finlandia ci tengono la mano. La Svizzera segue, e non lontane sono Norvegia e Svezia, tutti paesi di antica nobiltà atletica.
Occorerebbe una grande opera missionaria, per ridare a questi popoli la loro originaria religione. Non serve, a questo punto, andare in paesi lontani, in posti sperduti, a diffondere il verbo atletico. È imperativo, perchè l’atletica sopravviva, che si rieduchi la gioventù europea.
A chi l’arduo compito?
L’impressione è che non ci siano missionari all’altezza, e che soprattutto il blocco calcistico fatto dalla commistione tra interessi miliardari e informazione televisiva sia così potente, e imbattibile, da bloccare ogni inversione di tendenza. Proprio come avviene, a parti rovesciate, negli Stati Uniti: dove football, baseball, basket e hockey tengono il calcio fuori dai grandi circuiti di informazione-spettacolo.