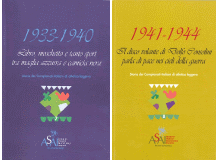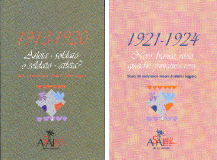My Way, a modo mio, la canzone partita dalla Francia, trascritta da Paul Anka negli States, e lì resa immortale dalla interpretazione di Frank Sinatra. Ne abbiamo presi alcuni brani e li dedichiamo a Elio Locatelli. Ci sembrano versi che ben s’adattano a lui, a lui che, più rapido di un velocista, diciamo pure di quell’Usain Bolt di cui tanto parlava, se è andato, settantaseienne ancora pieno di energie, vitalità aggressiva, voglia di non scendere dalla ribalta. Se ne è andato in un batter di ciglia, in quella Montecarlo dove aveva vissuto parecchi anni, scorrazzando però per il mondo, senza sosta. In quella Montecarlo – per noi italiani, in effetti Principato di Monaco per i precisini – dove, anche dopo la separazione dai corridoi sdrucciolevoli della Federatletica mondiale che si affaccia su Port Hercule, aveva mantenuto un appiglio, a cui si aggrappava di tanto in tanto per le più varie sue esigenze. In fondo, quello scampolo di terra rubata al mare e su cui è stata edificata una città, ha sempre avuto una forte attrazione per l’italica gente. Ed Elio, lì, ci aveva vissuto in pianta semistabile – viaggi da globetrotter a parte – come parecchi altri connazionali nostri, attirati dalla calamita atletica.
Elio Locatelli, di Canale d’Alba, figlio di noto e rispettato partigiano, un punto cardinale per tutta la sua vita. Giovane, parte dalle corse campestri con gli Studenteschi, poi vira verso il pattinaggio veloce, speed ed equilibrio, due altre caratteristiche in ogni azione del prof, nel camminare, nel parlare, nel mangiare, anzi divorare, cambiare di opinione. Due partecipazioni olimpiche nello sport del ghiaccio, poi l’atletica, nell’ambiente torinese dove era già in forte ascesa la cometa Primo Nebiolo. E poi, e poi…un elenco che anche a volerlo dipanare tutto sarebbe pur sempre incompleto. Allenatore con una predilezione per i salti, il lungo in particolare, componente dello staff tecnico della Federazione, spesso un dentro e fuori tipico di questi ambienti e dei vari chiari di luna «politici», ma Elio non era tipo che poteva essere messo da parte facilmente. Fino alla ascesa al vertice della piramide: commissario tecnico, e, a giudizio di chi lo ha visto all’opera da vicino, l’unico alle nostre latitudini che sapesse fare questo mestiere. Scrivania poca, mobilità tanta, bollette del telefono da arricchire le varie telecom. Ma nessuno poteva rimproverargli di non parlare con gli atleti, con i tecnici, con le società. A modo suo, my way, appunto, ma non gli sfuggiva quasi nulla. Accattivante con quei tali che devono riempire gli spazi su un foglio di carta fra un annuncio pubblicitario e l’altro.
Nel 1994, intuendo – aveva un fiuto da cane da trifola delle sue terre langarole – che buttava male, scrisse al presidente di allora una lettera di poche righe, che fece leggere in anticipo a un collega e poi lo portò a cena, dove parlò soprattutto di sua figlia Manuela, della sua specializzazione da archivista e di un corso importante organizzato dal Vaticano cui la ragazza era stata ammessa. Il giorno dopo lasciò il palazzetto di Via della Camilluccia. Destinazione? Incerta al momento. Tutti davano per scontato che avesse già in tasca un contratto firmato da Nebiolo per un posto a Montecarlo. Non era così, ma sarebbe poi stato così.
Gli anni della IAAF contribuirono a dare spessore alla sua caratura internazionale: progetti, convegni, contatti, il Master alla prestigiosa Scuola di Lione. Poi comincia a scricchiolare la struttura dell’ente mondiale, con vicende che coinvolgono i vertici. Locatelli sembra stare un po’ dentro, un po’ fuori, Montecarlo resta comunque, seppur parzialmente, il suo approdo. Per lui si aprono altre porte: il Comitato olimpico italiano gli offre un ruolo in considerazione dei suoi trascorsi e della sua innegabile competenza tecnica. Fino al giorno in cui ritorna al timone della Nazionale di atletica leggera, dovendosi occupare degli atleti di vertice, quelli che nei grandi eventi internazionali dovrebbero riportare a casa quella che, alla fine, piaccia o no, è l’unica cosa che conta per gli appassionati, per i media, per gli stessi gestori dello sport nazionale: qualche medaglia, di qualsiasi colore sia, sei poi brilla tanto meglio. Il professore ci prova, ma il compito che gli è stato affidato è improbo. Fino a quando, dopo i Campionati d’Europa 2018, lo pilotano verso altro incarico, diciamo, meno di «trincea» ma più didattico. A un uomo di vasta preparazione tecnica come lui è un invito a nozze. Il suo dinamismo lo porta ovunque; fino a non molti giorni fa, ci dicono gli amici presenti, era a un convegno in Veneto a portare il verbo tecnico che conosceva così bene. Ci ha detto un giornalista: «Ho sempre avuto grande rispetto di un uomo che si è costantemente aggiornato, che studiava, che conosceva, che si confrontava alla pari con i più bravi». Grande verità, anche se talvolta non era facile seguirlo nei suoi ragionamenti espressi sempre in velocità superiore alla comprensione media. Buttava lì un mozzicone di frase, un concetto, masticando il suo toscanello. E se capivi, bene, altrimenti rimanevi un po’ disorientato.
Elio Locatelli, ci ha detto un suo amico da una sessantina d’anni, «è morto da Elio Locatelli, sempre di corsa, o sul filo dei pattini del ghiaccio, o guidando l’auto a manetta, o cercando di spiegarti qualche diavoleria per sviluppare l’atletica a Papua New Guinea». Gli amici, soprattutto quei pochi di Montecarlo che hanno passato qualche anno con lui vicini di banco, lo avevano soprannominato «L’Ambasciatore», lo trovavi nel corridoio, era appena tornato dalla Mongolia, e stava già partendo per la Patagonia. Stavolta è partito per vedere se da qualche parte, lassù, qualcuno parla di salti, di piste, di preparazione, di programmazione, di sviluppo. E se per caso, dovesse mai ritrovare Primo Nebiolo, immagina il casino! Tutto in strettissimo piemontese, Bòja Fàuss.